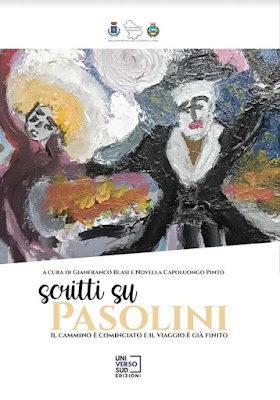“Con la sua lunga e brillante carriera ha scritto un importante capitolo della musica leggera e per riflesso un importante capitolo della nostra vita, perché la musica fa parte della vita di ognuno di noi e quando le canzoni riscuotono un successo intramontabile come quelle di Ivano Fossati, è impossibile non averle ascoltate e persino trovarvi similitudini e assonanze con momenti della nostra vita”. E’ l’inevitabile premessa del Rettore Francesco Delfino che rimanda a quelle che Proust ha definito “intermittenze del cuore” e che Pier Paolo Pasolini ha codificato nelle sue riflessioni sul significato e la forza delle “canzonette”, quel soprassalto emozionale ed esistenziale provocato da brani come “La costruzione di un amore”, “Carte da decifrare”, “C’è tempo”, “Treno di ferro”, e mi fermo qui perché da “Un’emozione da poco” in poi l’elenco sarebbe lunghissimo.
“Nella diffusione della cultura ha dato prova di sensibilità e profondità, capace di instaurare un dialogo e veicolare contenuti proprio come ha sempre fatto con le sue canzoni”, prosegue il Rettore, facendo riferimento al laboratorio tenuto da Fossati presso l’Ateneo genovese dal 2016 al 2018, dal titolo “Linguaggi, figure professionali e meccanismi produttivi della canzone”.
Ed ora lì, dopo la pausa per la pandemia, nell’aula San Salvatore di Sarzano dell’Università di Genova, nel cuore antico e autentico della città, Ivano Fossati ha ricevuto la laurea honoris causa in Lettere moderne e spettacolo.
Prima di dare la parola al neolaureato, il saluto di Duccio Tongiorgi, direttore del Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo, e la “Laudatio” affidata al Preside della Scuola di Scienze umanistiche, il musicologo Raffaele Mellace.
“All’arido elenco di gesta, ho preferito la forma artistica dell’acrostico” ha detto il professor Mellace : 7 parole che rimandano a 7 mondi espressi dal “candidato” alla Laurea ad honorem “per attraversarli con qualche consapevolezza”. Li riporto in sintesi.
F come FIATO, l’elemento essenziale della musica e del canto.
O come ORCHESTRA, l’importanza dello strumentale nella ricerca di Ivano Fossati, polistrumentista, collezionista di strumenti
S come SCRITTORE, l’immaginario poetico che abbiamo interiorizzato
S come SUONO, un timbro e un sound inconfondibile, pacato, introspettivo con impennate melodiche
A come ALTRI REGISTRI, dal piano pianissimo alla vitalità ritmica
T come TEATRO, un artista che vive di lenta costruzione, che si sgancia dalla macchina della produttività forzata per vivere il proprio flatus artistico in un’altra dimensione, rinunciare ad alimentare l’illusione dell’eterna giovinezza
I come IDEA osservare prima di raccontare: prima che con il talento, le canzoni si scrivono con gli occhi.
Dopo la laudatio, la vestizione di Fossati, la formula di rito, ecco l’attesissima lectio magistralis. Il titolo è “Ispirazione, pensiero e sintesi nella musica discografica” e comincia con questa frase: “L’ispirazione non ha limiti” ed è il filo conduttore del discorso di Fossati durato una ventina di minuti. In questo territorio "sconfinato" arriva il "miracolo della riproduzione", la prima tecnologia discografica alla fine dell’Ottocento, il fonografo:
“Doveva sembrare un miracolo portarsi a casa le grandi orchestre, le arie d’Opera, i più celebri cantanti lirici, ora siamo assediati dalla sovrapproduzione di musica o di qualcosa che vorrebbe somigliarle. E’ anche troppo. Quell’antico stupore non lo possiamo nemmeno immaginare. Le arie d’Opera vengono mutilate per poter essere contenute nei fatidici quattro minuti. Via l’introduzione orchestrale, via gli interludi, spesso via anche parti cospicue della composizione, si salva solo quello che tutti conoscono, l’aria celeberrima che a casa la gente canticchia con le parole sbagliate dentro la vasca da bagno. Di conseguenza in quel periodo si produce un gran numero di dischi che fanno inorridire gli intenditori, ma accontentano i primi audiofili di bocca buona che faranno il successo dell’industria discografica che sta nascendo. Gli autori di canzoni, allora si diceva canzonette, erano musicisti preparati, venivano dal Conservatorio, avevano in mente la canzone declinata come un’opera lirica in sedicesimi, le partiture con lunghe introduzioni orchestrali, lunghe strofe, brevi interludi e poi la parte centrale che qui, da noi, chiamiamo ritornello, o meglio, chiamavamo ritornello, seguito da ripetizioni e pomposo finale. Questi autori però non si fanno grossi problemi se la canzone viene tagliata nella sua versione discografica.
Nasce così il primo patto degli artisti con l’industria e il patto è sacrificio e asservimento dell’ispirazione in cambio di notorietà e possibilmente di ricchezza, una sorta di patto col diavolo, ma io mi permetto di avere qualche dubbio in proposito, ma ci arriveremo più tardi…
Tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni Sessanta del secolo scorso accade qualcosa di mai visto prima, l’incontro-scontro (oggi si direbbe la tempesta perfetta) fra una nuovissima tecnologia, il disco microsolco a 45 giri, la riverberazione massiccia attraverso l’Inghilterra, di molta musica del Sud del mondo, soprattutto il blues che è il padre di quasi tutta la musica discografica leggera, una nuova generazione di musicisti autori, autodidatti, spesso di grande talento e grande determinazione che però, la porta di un Conservatorio, non l’ha mai varcata.
E’ curioso che la musica del Sud del mondo ci sia arrivata dall’Inghilterra, il rhythm’n blues ha preso forza in Europa e soprattutto qui da noi fra il 1968 e 69, mentre già nel ’62 i musicisti inglesi portavano verso di noi il blues.
Adesso il tempo disponibile su disco scende addirittura a 2 minuti e mezzo. Utilizzano slogan, crasi, espressioni gergali e invenzioni fonetiche. La sintesi nelle primissime canzoni dei Beatles è da manuale, nessuna parte necessaria viene tralasciata, tutto è fulmineo, organico, simmetrico, in una parola efficace. La musica nera che hanno molto ascoltato è una grande scuola di sintesi e nelle loro canzoni ce n’è più di una traccia. Il resto viene dal talento e dalla curiosità.
Qualche anno fa con il professore Ferdinando Fasce abbiamo fatto una piccola ricerca, eravamo curiosi di capire quanta musica nera ci fosse nelle canzoni dei Beatles che apparivano, appaiono, come la cosa più inglese che si potesse immaginare. Ebbene, un quinto delle loro canzoni sono innestate sopra un impianto di musica che deriva dal blues, basti pensare a titoli come “Come toghether”, forse la canzone più nera che abbiano scritto, a “Taxman” che è un vero rhythm ‘n blues. Così il pensiero viene addomesticato dall’intelligenza, costretto ad abitare in spazi ristretti. Anche artisti come Bob Dylan e Paul Simon, soprattutto all’inizio, combattono la loro battaglia contro il tempo e allora cambiano la forma canzone dall’interno, dal contenuto, con la forza dell’ispirazione e del pensiero che la sovrasta. Gli artisti, i migliori, i più grandi hanno sempre guardato verso l’alto. Le loro biografie e le confessioni fatte a vario titolo sono piene di riferimenti alla letteratura e alla poesia, quasi tutti citano un ispiratore, una guida: Faulkner, Kerouac, Ferlinghetti, Gregory Corso, chi si dice folgorato da Henry Miller e chi da Céline. In tanti, uomini e donne, ammettono di dovere qualcosa alla scrittura asciutta e diretta di Hemingway. Paul McCartney mentre scriveva “Lady Madonna” sappiamo che frequentava i concerti di musica contemporanea, per esempio la musica di Luciano Berio, il leader degli Who, Pete Thownshend, mentre faceva a pezzi la chitarra sul palcoscenico per la gioia del suo pubblico, si faceva ispirare quasi in segreto dalla musica minimalista di Terry Riley e Jimi Hendrix da Stravinsky. Di questa ispirazione rimane sempre una traccia nitida, l’ispirazione piove dal cielo sì, ma occorre essere pronti e curiosi e guardare verso l’alto.
Per me, invece, quando avevo 18 anni c’è stato Cesare Pavese col suo sguardo modernissimo, quasi cinematografico sulle cose, con i suoi scenari allargati, le colline delle Langhe filtrate attraverso tanta letteratura americana che lui amava, descritte col grandangolo, vaste come scenari alla Joseph Conrad, vaste come in fondo non erano mai state. E poi George Simenon che non ha troppo tempo per gli aggettivi e ci concede per immaginare le sue ambientazioni solo brevi tratti di penna e di colore, il lavoro lo fa fare a noi che leggiamo. È tutto perfetto, funziona, noi immaginiamo e vediamo come vuole lui, è una grande lezione per un narratore da tre minuti, come sono anch’io e quella di Simenon è esattamente la tecnica delle canzoni. Non c’è spazio in 3 minuti e mezzo per dire tutto, bisogna fare dei tratti e dei tagli che aiutino l’immaginazione degli altri, tu scrivi ed è il pubblico che costruisce. Mi viene in mente “Eleanor Rigby”, ma non lo sa neanche McCartney cosa vuol dire, non lo dico io, l’ha detto lui. È un’associazione di idee, ma è perfetta, ed è talmente giusta ed evocativa, che noi ci abbiamo lavorato sopra per cinquant’anni e ognuno di noi l’ha vista a modo suo. Per fortuna non è stato mai fatto un video, perché il video che ci siamo immaginati noi è molto meglio e soprattutto è personale, per ognuno di noi è diverso. Quello è il mestiere che bisogna saper fare, scrivere pochissimo e lasciare immaginare molto.
E poi, per puro esempio, voglio citare anche uno scrittore più vicino a noi nel tempo attuale, Irvine Welsh, che mostra magistralmente solo il necessario ma efficacemente, anche quando il necessario deve essere duro, intricato, turpe, cinico, sarcastico insieme. Anche Irvine Welsh è di grande utilità, dato che oggi tutti noi parliamo più come lui che come Dostoevskij. E il linguaggio si modifica rapidamente, giorno dopo giorno. “Il segreto di annoiare sta nel dire tutto” sono le parole di Voltaire che bisogna tenere a mente, soprattutto quando sappiamo che la musica è un nastro trasportatore che non aspetta.
Metodi di sintesi letteraria musicale li ho sempre personalmente ricavati dai nostri dialetti e dalle lingue diverse dalle mie ritraducendo poi in italiano. Le espressioni napoletane messe in musica si prestano a rapide dolcezze carezzevoli, il nostro caro genovese, utilissimo nella ricerca di forme stringate, è lapidario e sarcastico insieme. Le formule di costruzione semantiche dell’inglese risultano quasi sempre scorrevoli e adattabili, anche se con il rischio di qualche eccessiva semplificazione e poi c’è il portoghese, una delle lingue più musicali che si conoscano, che dal suo interno offre soluzioni inaspettate di grande aiuto. Il nostro italiano è amabile, completo ricchissimo di sfumature e di profondità, ma spigoloso e non sempre è amico della metrica musicale più attuale. Sappiamo che garantisce bellissimi risultati solo a costo di cura, inventiva e laboriosità.
E veniamo a oggi. Oggi nemmeno la tecnologia digitale ha vinto sulla durata della musica, adesso che quest’ultima non avrebbe più limiti, nessun network trasmetterebbe brani di 6/7 minuti o più. In rete è diverso, ma nella pratica produttiva comune poco è cambiato, e forse è un bene, dico io. La musica che può permettersi spazi più ampi è un’altra, è differente, ha altre strutture e obiettivi diversi. E intanto, la lunga marcia della musica proveniente dal Sud del mondo si può considerare conclusa, la black music ha vinto quasi su tutto, ha arricchito, impreziosito, snellito le nostre modalità espressive, le classifiche sono dominate dal rap in tutte le sue forme, e da un r’n’b che col rhythm ‘n blues delle origini non ha niente a che fare o poco. La capacità fonetica, vocale di alcuni rapper a volte è notevole, agiscono sul ritmo come percussionisti, scomponendo il tempo e creando fra il significato e il suono delle parole vere e proprie poliritmie complesse. Mi chiedo cosa ne penserebbero i futuristi. Marinetti, ascoltando il rap si sentirebbe finalmente appagato? Chi può escluderlo? Questi generi musicali, figli e nipoti del blues, della black music, con influenze latine e caraibiche, si fondono e si influenzano a vicenda, accerchiano e assediano anche la forma canzone che conosciamo e la canzone si concede volentieri a questa trasformazione, lascia entrare dentro la propria struttura modalità e linguaggi differenti, non nuovi però, perché il rap viene da lontano e non è certo una moda del momento. Anch’esso si modificherà, già adesso si lascia integrare da forme ritmiche e melodiche di origine orientale e maghrebina, ma è qui per restare.
Se oggi penso alla trasformazione della musica e dell’ispirazione che la genera, in prodotto discografico, in emozione portatile istantanea come un file digitale, allora penso a quel maestoso insieme, rotolante, in continuo movimento, fatto di alto e di basso, di musica sublime, di arte, di idee folgoranti, letteratura, di parole toccanti che ha sempre condiviso il proprio cammino con tanta piccola musica forse insignificante e presto dimenticata. E’ quell’insieme, quel tutto, il prodotto meraviglioso di cui parliamo. Musica alta, musica leggera e musica leggerissima: io ho amore per tutte. Quell'insieme rumoroso, chiassoso, incessante, che ci ha cresciuti e che ci accompagna, ci spinge avanti guardando verso l'alto, al nostro posto, soprattutto quando noi ci stanchiamo o non siamo più capaci di farlo. Musica e pensieri nati per essere commercializzati e per fare soldi, che tuttavia dall’interno di un enorme ingranaggio, sono in grado di mostrare i cieli più alti, di mettere le anime a nudo, di insegnarci qualcosa, passo dopo passo, e senza l’aria di volerlo o di poterlo fare. Se questa meraviglia è il risultato del patto fra gli artisti e l’industria discografica e se, come si dice, in questo patto faustiano c’è lo zampino del diavolo, allora non sono certo che l’industria sia il diavolo, sarebbe un diavolo perdente. L’ispirazione è ancora lassù al suo posto, integra, fulgida, pronta a tutto come sempre, pronta per nuove generazioni di artisti visionari, mentre l’industria, dobbiamo riconoscerlo, ha conosciuto tempi migliori. Per questo ho il sospetto che nel vecchio patto, ispirazione e talento, in cambio di fama e denaro, la parte del diavolo astuto l’abbiano fatta in realtà e di certo inconsapevolmente gli autori e gli artisti, proprio tutti, i grandi e i dimenticati. Ho il sospetto che quel lontano giorno, per una volta, forse, il diavolo eravamo noi".
i miti di timi
martedì 28 marzo 2023
giovedì 8 settembre 2022
Che cosa sono le canzoni? Un "Capriccio all'italiana" - Intervista possibile: Pier Paolo Pasolini e la musica
Se non avesse fatto lo scrittore e il poeta, cosa avrebbe scelto di fare Pier Paolo Pasolini?
Avrei fatto lo scrittore di musica.
Che musica ascolta?
Genericamente della musica classica, sono ossessionato da Bach e da Mozart e quando non ascolto musica classica, allora cerco la musica popolare, ma quella vera, quella raccolta dagli etnologi, quella che ho adoperato nel commento musicale di “Medea”, i canti tibetani popolari, i canti d’amore iraniani, ma non riesco mai a staccarmi da Bach e da Mozart.
La musica leggera quindi non le interessa?
Amando la vita sotto tutti i punti di vista, la amo, in un certo senso, anche in questo suo aspetto che io considero intellettualmente piuttosto volgare, di basso livello in Italia.
Quale aspetto, dunque, la incuriosisce?
La musica leggera italiana mi sembra veramente brutta, però ci sono certi dei momenti in cui non si può prescindere dal fatto che questa musica leggera ci sia. Risentendo certe canzonette di dieci anni fa, c’è quel fenomeno che Proust chiama “Les intermittences du coeur”. Sentendo delle note, pur stupide, di dieci anni fa, improvvisamente quel brano appare ai nostri occhi… nel ricordo acquista un’altra valenza, attraverso il sentimento che ci mettiamo, ma di per sé, la canzonetta ha scarso valore. Voglio dire che le canzoni, anche se non sono belle, possono essere importanti per noi per i ricordi che evocano. Quindi la musica leggera è misteriosamente legata alla nostra vita quotidiana e di conseguenza un certo amore ce l’ho, ma a livello intellettuale devo fare delle scelte piuttosto rigorose.
Lei non ha qualche ricordo legato a una canzone?
Un ricordo particolare non direi, le canzoni non sono mai entrate così a fondo nella mia vita privata da legarsi a un episodio privato della mia vita, più che altro evocano atmosfere, ricordi di certi periodi. In questo senso potrei dire che c’è una canzonetta, “Amado mio” cantata da Rita Hayworth, che mi evoca i tempi in cui andavo a ballare nelle balere friulane, quindi le estati un po’ umide del Friuli della mia gioventù.
Ci dica almeno un nome nell’ambito della musica leggera che ha ascoltato recentemente…
L’unica musica contemporanea che mi è piaciuta di questi tempi è quella dei Beatles e dei Rolling Stones, in Italia forse l’Equipe 84…
Allora qualche “canzonetta” che ha attirato la sua attenzione c’è…
Sulle canzonette potrei dare due tipi di risposte del tutto contrarie, niente meglio delle canzonette ha il potere magico abiettamente poetico di rievocare un tempo perduto. Sfido chiunque a rievocare il dopoguerra meglio di quello che possa fare il boogie woogie o l’estate del ’63, meglio di quel che possa fare “Stessa spiaggia stesso mare”. Les intermittences du coer più violente, cieche e irrefrenabili, sono quelle che si provano ascoltando una canzonetta. Chissà perché i ricordi delle sere o dei pomeriggi o dei mattini della vita si legano così profondamente alle note che infila nell’aria una stupida radiolina o una volgare orchestra, e anche la parte odiosa, repellente di un’epoca aderisce per sempre alle note di una canzonetta. Pensate a “Pippo non lo sa”. Ad ogni modo, non sono un buon giudice. Soffro di antipatie e simpatie profonde per i cantanti e le melodie, il massimo dell’antipatia è per la canzonetta crepuscolare, di cui potrei dare come paradigma “Signorinella pallida”. Aggiungo infine che non mi dispiace il timbro orgiastico che hanno le musiche trasmesse dai juke-box. Tutto ciò è vergognoso, lo so, e quindi devo dire che il mondo delle canzonette è oggi un mondo sciocco e degenerato, non è popolare, ma piccolo borghese e come tale profondamente corruttore. La tv è colpevole della diseducazione dei suoi ascoltatori anche per questo. I fanatismi per i cantanti sono peggio dei giochi del circo.
In questo scenario decadente, nemmeno un barlume?
Occorre operare un esercizio critico, rischiare l’impopolarità ma andare contro la componente passiva e fanatica, soprattutto nei giovani.
Quindi lei pensa che attraverso la canzone non si possano lanciare messaggi dire cose importanti…
Io non generalizzo, ci sono certe canzoni napoletane della fine dell’800 e del principio del Novecento che non davano nessun messaggio di carattere politico o ideologico, erano semplicemente canti d’amore o d’allegria o di vitalità, eppure erano bellissimi e così certe canzonette francesi, molto poetiche. Io stavo parlando, in particolare, della musica leggera italiana dagli anni ’30, quando ero ragazzo io, ad oggi, credo che non abbia mai avuto un momento di poesia o realismo, è stata sempre una cosa superficiale, puramente commerciale.
Da Scapricciatiello a corde della mia chitarra, nei suoi libri cita alcune canzoni, che funzione hanno in quel caso le “canzonette”?
Fanno parte di quello che in letteratura si chiama il discorso libero indiretto. Nel mio libro ci sono molti brani in cui non esprimo i miei pensieri, ma parlo attraverso i pensieri del mio personaggio e quindi attraverso i suoi miti, il suo modo di mettersi in rapporto con il mondo, il suo modo di giudicare gli altri uomini, e quindi anche attraverso le parole delle canzoni. Io queste parole non lo so, ho dovuto andarmi ad informare, ma siccome so che dentro i miei personaggi, mettiamo Tommasino Puzzilli de “La vita violenta”, queste parole ci sono e fanno parte della sua cultura, allora ho citato brani interi di canzoni. In qualche modo, Claudio Villa di allora o Giacomo Rondinella, in un modo, certo, sempre falsato, manipolato e alienante, avevano un punto di contatto col reale gusto culturale musicale del sottoproletariato del tempo. L’epoca di “Scapricciatiello”, “Io sono carcerato”, oppure “Luna rossa” ha rappresentato un momento in cui le canzoni hanno colto un momento popolare abbastanza vero.
Cosa le piace di Claudio Villa?
Mi piace il repertorio delle canzoni melodiche di Claudio Villa perché mi piace il pubblico che ama questo stile popolare e verace. Approvo che Villa scriva, musichi e interpreti le sue canzoni. Lui lo fa nel suo piccolo come Charlot ha fatto nel suo grande. In quanto agli atteggiamenti da bullo, la presunzione e gli atteggiamenti d’insufficienza che gli si imputano, io trovo che nella sua qualità di cantante-attore e di personaggio dello spettacolo tali atteggiamenti gli si addicano, perché fanno, appunto, spettacolo. Disapprovo invece che Claudio Villa sia dia a interpretazioni del genere urlato, anche perché io credo nella canzone come mezzo verace d’espressione e penso che il genere urlato non sia genuino. Le canzoni andrebbero portate a un livello d’espressione più interessante.
Su “Il Tempo” del 15 febbraio 1969 lei ha scritto: "È cominciato ed è finito il Festival di Sanremo. Le città erano deserte; tutti gli italiani erano raccolti intorno ai loro televisori. Il Festival di Sanremo e le sue canzonette sono qualcosa che deturpa irrimediabilmente una società”
Le cose sono andate ancora peggio del solito: perché c’è stata una contestazione, seppur appena accennata, al Festival. Si contestano i prezzi dei biglietti per ascoltare quelle povere creature che cantano quelle povere idiozie: e si protesta moralisticamente contro il privilegio di chi può pagare il prezzo di quei biglietti. Non ci si rende conto che tutti i sessanta milioni di italiani, ormai, se potessero godere di questo famoso privilegio, pagherebbero il prezzo di quel biglietto e andrebbero ad assistere in carne e ossa allo spettacolo di Sanremo. Non è questione di essere in pochi a poter pagare quelle miserabili ventimila lire ma è questione che tutti, se potessero, pagherebbero. Tutti, operai, studenti, ricchi, poveri, industriali, braccianti... I centomila disgraziati che si tappano le orecchie e si coprono gli occhi davanti a questa matta bestialità, sono abitanti di un ghetto che si guardano allibiti fra loro, senza speranza. E i più non osano neanche parlarne: perché parlarne, sinceramente, fino in fondo, fino all'indignazione, è impopolare come niente altro. E' per non rischiare questa impopolarità, che i contestatori sono in questo caso tanto discreti. Ma è un calcolo sbagliato, che li rende degni degli "innocenti" cantanti integrati e del loro pubblico."
Attualmente molti registi scelgono cantanti come attori anche in film impegnati, ad esempio Germi ha scelto Celentano per il ruolo di Serafino, Morandi ha recitato in diversi “musicarelli”. Lei sceglierebbe qualcuno dei nostri cantanti come attore?
Sono cose che non posso mai dire prima, perché io scelgo un attore soltanto in funzione del personaggio. Se avessi scritto un certo personaggio con certi caratteri fisici, potrei benissimo scegliere Gianni Morandi, perché no? Ha un bel viso, è un ragazzo simpatico, avendo un personaggio con quelle caratteristiche potrei scegliere lui, ma non lo posso calcolare a priori.
Nel frattempo, però, è diventato anche un autore di canzoni. Com’è nata la collaborazione con Sergio Endrigo per il brano “Il soldato di Napoleone”?
E’ stato il direttore artistico della RCA, Ennio Melis, a farci incontrare. Endrigo aveva 27 anni, era di undici anni più giovane di me e aveva già scritto “Io che amo solo te”, “Aria di neve”, “Viva Maddalena” e altre. Tra queste altre c’era anche “Via Broletto”, un testo che poteva far pensare ad alcune ambientazioni o atmosfere che ho descritto nei miei romanzi, ambientati a Roma e nelle sue periferie. Tuttavia, di Endrigo mi interessava la sua storia di esule istriano, le nostre comune origini, lui è nato a Pola, io a Casarsa della Delizia, Trieste a metà strada. Così gli chiesi di cercare fra le mie poesie friulane pubblicate ne “La meglio gioventù” e di musicarne una a suo piacimento e lui scelse “Il soldato di Napoleone”. In calce all’originale friulano, c’era già una mia versione in italiano ed Endrigo partì da quella, senza modificare nulla, se non lo stretto necessario per adattarlo alla metrica della musica che aveva scritto. Per cantarla in televisione ci chiesero di eliminare alcuni versi che la commissione censura ha definito “disgustosi”, noi naturalmente rifiutammo.
Erano versi ispirati alle memorie di famiglia, tra realtà e leggenda.
E’ il racconto delle gesta di un avo della famiglia di mia madre che si era arruolato con i francesi ed era andato a combattere in Polonia. I versi non graditi dalla televisione sono quelli legati a un particolare che nella famiglia Colussi si tramanda oralmente da generazioni. Una notte il giovane soldato, per non morire di freddo, squarciò il ventre al suo cavallo caduto in battaglia e si scaldò con le sue viscere.
Alcune di queste canzoni saranno cantate anche tra cinquant’anni...
Ho scritto due canzonette per Laura Betti, e poi facendo una specie di collage prendendo dei versi da “L’Otello” di Shakespeare, una breve canzone da inserire in un mio episodio che si intitola “Che cosa sono le nuvole” che faceva parte del film “Capriccio all’italiana”, queste mie parole le ha musicate Modugno, e devo dire che l’ha fatto molto bene.
(Le risposte di Pier Paolo Pasolini sono tratte da alcuni suoi scritti, da dichiarazioni di Sergio Endrigo e dalle interviste in diversi programmi Rai, raccolte recentemente da Elisabetta Malantrucco nello speciale di RaiPlaySound “Pasolini, appunti musicali”)
Testo di Timisoara Pinto inserito nel libro "Scritti su Pasolini. Il cammino è cominciato e il viaggio è già finito a cura di Gianfranco Blasi e Novella Capoluongo Pinto (Universosud)
Avrei fatto lo scrittore di musica.
Che musica ascolta?
Genericamente della musica classica, sono ossessionato da Bach e da Mozart e quando non ascolto musica classica, allora cerco la musica popolare, ma quella vera, quella raccolta dagli etnologi, quella che ho adoperato nel commento musicale di “Medea”, i canti tibetani popolari, i canti d’amore iraniani, ma non riesco mai a staccarmi da Bach e da Mozart.
La musica leggera quindi non le interessa?
Amando la vita sotto tutti i punti di vista, la amo, in un certo senso, anche in questo suo aspetto che io considero intellettualmente piuttosto volgare, di basso livello in Italia.
Quale aspetto, dunque, la incuriosisce?
La musica leggera italiana mi sembra veramente brutta, però ci sono certi dei momenti in cui non si può prescindere dal fatto che questa musica leggera ci sia. Risentendo certe canzonette di dieci anni fa, c’è quel fenomeno che Proust chiama “Les intermittences du coeur”. Sentendo delle note, pur stupide, di dieci anni fa, improvvisamente quel brano appare ai nostri occhi… nel ricordo acquista un’altra valenza, attraverso il sentimento che ci mettiamo, ma di per sé, la canzonetta ha scarso valore. Voglio dire che le canzoni, anche se non sono belle, possono essere importanti per noi per i ricordi che evocano. Quindi la musica leggera è misteriosamente legata alla nostra vita quotidiana e di conseguenza un certo amore ce l’ho, ma a livello intellettuale devo fare delle scelte piuttosto rigorose.
Lei non ha qualche ricordo legato a una canzone?
Un ricordo particolare non direi, le canzoni non sono mai entrate così a fondo nella mia vita privata da legarsi a un episodio privato della mia vita, più che altro evocano atmosfere, ricordi di certi periodi. In questo senso potrei dire che c’è una canzonetta, “Amado mio” cantata da Rita Hayworth, che mi evoca i tempi in cui andavo a ballare nelle balere friulane, quindi le estati un po’ umide del Friuli della mia gioventù.
Ci dica almeno un nome nell’ambito della musica leggera che ha ascoltato recentemente…
L’unica musica contemporanea che mi è piaciuta di questi tempi è quella dei Beatles e dei Rolling Stones, in Italia forse l’Equipe 84…
Allora qualche “canzonetta” che ha attirato la sua attenzione c’è…
Sulle canzonette potrei dare due tipi di risposte del tutto contrarie, niente meglio delle canzonette ha il potere magico abiettamente poetico di rievocare un tempo perduto. Sfido chiunque a rievocare il dopoguerra meglio di quello che possa fare il boogie woogie o l’estate del ’63, meglio di quel che possa fare “Stessa spiaggia stesso mare”. Les intermittences du coer più violente, cieche e irrefrenabili, sono quelle che si provano ascoltando una canzonetta. Chissà perché i ricordi delle sere o dei pomeriggi o dei mattini della vita si legano così profondamente alle note che infila nell’aria una stupida radiolina o una volgare orchestra, e anche la parte odiosa, repellente di un’epoca aderisce per sempre alle note di una canzonetta. Pensate a “Pippo non lo sa”. Ad ogni modo, non sono un buon giudice. Soffro di antipatie e simpatie profonde per i cantanti e le melodie, il massimo dell’antipatia è per la canzonetta crepuscolare, di cui potrei dare come paradigma “Signorinella pallida”. Aggiungo infine che non mi dispiace il timbro orgiastico che hanno le musiche trasmesse dai juke-box. Tutto ciò è vergognoso, lo so, e quindi devo dire che il mondo delle canzonette è oggi un mondo sciocco e degenerato, non è popolare, ma piccolo borghese e come tale profondamente corruttore. La tv è colpevole della diseducazione dei suoi ascoltatori anche per questo. I fanatismi per i cantanti sono peggio dei giochi del circo.
In questo scenario decadente, nemmeno un barlume?
Occorre operare un esercizio critico, rischiare l’impopolarità ma andare contro la componente passiva e fanatica, soprattutto nei giovani.
Quindi lei pensa che attraverso la canzone non si possano lanciare messaggi dire cose importanti…
Io non generalizzo, ci sono certe canzoni napoletane della fine dell’800 e del principio del Novecento che non davano nessun messaggio di carattere politico o ideologico, erano semplicemente canti d’amore o d’allegria o di vitalità, eppure erano bellissimi e così certe canzonette francesi, molto poetiche. Io stavo parlando, in particolare, della musica leggera italiana dagli anni ’30, quando ero ragazzo io, ad oggi, credo che non abbia mai avuto un momento di poesia o realismo, è stata sempre una cosa superficiale, puramente commerciale.
Da Scapricciatiello a corde della mia chitarra, nei suoi libri cita alcune canzoni, che funzione hanno in quel caso le “canzonette”?
Fanno parte di quello che in letteratura si chiama il discorso libero indiretto. Nel mio libro ci sono molti brani in cui non esprimo i miei pensieri, ma parlo attraverso i pensieri del mio personaggio e quindi attraverso i suoi miti, il suo modo di mettersi in rapporto con il mondo, il suo modo di giudicare gli altri uomini, e quindi anche attraverso le parole delle canzoni. Io queste parole non lo so, ho dovuto andarmi ad informare, ma siccome so che dentro i miei personaggi, mettiamo Tommasino Puzzilli de “La vita violenta”, queste parole ci sono e fanno parte della sua cultura, allora ho citato brani interi di canzoni. In qualche modo, Claudio Villa di allora o Giacomo Rondinella, in un modo, certo, sempre falsato, manipolato e alienante, avevano un punto di contatto col reale gusto culturale musicale del sottoproletariato del tempo. L’epoca di “Scapricciatiello”, “Io sono carcerato”, oppure “Luna rossa” ha rappresentato un momento in cui le canzoni hanno colto un momento popolare abbastanza vero.
Cosa le piace di Claudio Villa?
Mi piace il repertorio delle canzoni melodiche di Claudio Villa perché mi piace il pubblico che ama questo stile popolare e verace. Approvo che Villa scriva, musichi e interpreti le sue canzoni. Lui lo fa nel suo piccolo come Charlot ha fatto nel suo grande. In quanto agli atteggiamenti da bullo, la presunzione e gli atteggiamenti d’insufficienza che gli si imputano, io trovo che nella sua qualità di cantante-attore e di personaggio dello spettacolo tali atteggiamenti gli si addicano, perché fanno, appunto, spettacolo. Disapprovo invece che Claudio Villa sia dia a interpretazioni del genere urlato, anche perché io credo nella canzone come mezzo verace d’espressione e penso che il genere urlato non sia genuino. Le canzoni andrebbero portate a un livello d’espressione più interessante.
Su “Il Tempo” del 15 febbraio 1969 lei ha scritto: "È cominciato ed è finito il Festival di Sanremo. Le città erano deserte; tutti gli italiani erano raccolti intorno ai loro televisori. Il Festival di Sanremo e le sue canzonette sono qualcosa che deturpa irrimediabilmente una società”
Le cose sono andate ancora peggio del solito: perché c’è stata una contestazione, seppur appena accennata, al Festival. Si contestano i prezzi dei biglietti per ascoltare quelle povere creature che cantano quelle povere idiozie: e si protesta moralisticamente contro il privilegio di chi può pagare il prezzo di quei biglietti. Non ci si rende conto che tutti i sessanta milioni di italiani, ormai, se potessero godere di questo famoso privilegio, pagherebbero il prezzo di quel biglietto e andrebbero ad assistere in carne e ossa allo spettacolo di Sanremo. Non è questione di essere in pochi a poter pagare quelle miserabili ventimila lire ma è questione che tutti, se potessero, pagherebbero. Tutti, operai, studenti, ricchi, poveri, industriali, braccianti... I centomila disgraziati che si tappano le orecchie e si coprono gli occhi davanti a questa matta bestialità, sono abitanti di un ghetto che si guardano allibiti fra loro, senza speranza. E i più non osano neanche parlarne: perché parlarne, sinceramente, fino in fondo, fino all'indignazione, è impopolare come niente altro. E' per non rischiare questa impopolarità, che i contestatori sono in questo caso tanto discreti. Ma è un calcolo sbagliato, che li rende degni degli "innocenti" cantanti integrati e del loro pubblico."
Attualmente molti registi scelgono cantanti come attori anche in film impegnati, ad esempio Germi ha scelto Celentano per il ruolo di Serafino, Morandi ha recitato in diversi “musicarelli”. Lei sceglierebbe qualcuno dei nostri cantanti come attore?
Sono cose che non posso mai dire prima, perché io scelgo un attore soltanto in funzione del personaggio. Se avessi scritto un certo personaggio con certi caratteri fisici, potrei benissimo scegliere Gianni Morandi, perché no? Ha un bel viso, è un ragazzo simpatico, avendo un personaggio con quelle caratteristiche potrei scegliere lui, ma non lo posso calcolare a priori.
Nel frattempo, però, è diventato anche un autore di canzoni. Com’è nata la collaborazione con Sergio Endrigo per il brano “Il soldato di Napoleone”?
E’ stato il direttore artistico della RCA, Ennio Melis, a farci incontrare. Endrigo aveva 27 anni, era di undici anni più giovane di me e aveva già scritto “Io che amo solo te”, “Aria di neve”, “Viva Maddalena” e altre. Tra queste altre c’era anche “Via Broletto”, un testo che poteva far pensare ad alcune ambientazioni o atmosfere che ho descritto nei miei romanzi, ambientati a Roma e nelle sue periferie. Tuttavia, di Endrigo mi interessava la sua storia di esule istriano, le nostre comune origini, lui è nato a Pola, io a Casarsa della Delizia, Trieste a metà strada. Così gli chiesi di cercare fra le mie poesie friulane pubblicate ne “La meglio gioventù” e di musicarne una a suo piacimento e lui scelse “Il soldato di Napoleone”. In calce all’originale friulano, c’era già una mia versione in italiano ed Endrigo partì da quella, senza modificare nulla, se non lo stretto necessario per adattarlo alla metrica della musica che aveva scritto. Per cantarla in televisione ci chiesero di eliminare alcuni versi che la commissione censura ha definito “disgustosi”, noi naturalmente rifiutammo.
Erano versi ispirati alle memorie di famiglia, tra realtà e leggenda.
E’ il racconto delle gesta di un avo della famiglia di mia madre che si era arruolato con i francesi ed era andato a combattere in Polonia. I versi non graditi dalla televisione sono quelli legati a un particolare che nella famiglia Colussi si tramanda oralmente da generazioni. Una notte il giovane soldato, per non morire di freddo, squarciò il ventre al suo cavallo caduto in battaglia e si scaldò con le sue viscere.
Alcune di queste canzoni saranno cantate anche tra cinquant’anni...
Ho scritto due canzonette per Laura Betti, e poi facendo una specie di collage prendendo dei versi da “L’Otello” di Shakespeare, una breve canzone da inserire in un mio episodio che si intitola “Che cosa sono le nuvole” che faceva parte del film “Capriccio all’italiana”, queste mie parole le ha musicate Modugno, e devo dire che l’ha fatto molto bene.
(Le risposte di Pier Paolo Pasolini sono tratte da alcuni suoi scritti, da dichiarazioni di Sergio Endrigo e dalle interviste in diversi programmi Rai, raccolte recentemente da Elisabetta Malantrucco nello speciale di RaiPlaySound “Pasolini, appunti musicali”)
Testo di Timisoara Pinto inserito nel libro "Scritti su Pasolini. Il cammino è cominciato e il viaggio è già finito a cura di Gianfranco Blasi e Novella Capoluongo Pinto (Universosud)
giovedì 12 maggio 2022
Altro che Arrivederci, Giorgio e Zsa Zsa decisero di non vedersi più...
Il ricordo di un amore e di una canzone nel giorno della nascita di Umberto Bindi
Non esisteva ancora l’espressione “Canzone d’autore” (creata da Enrico de Angelis nel ’69) e Umberto Bindi, padre della cosiddetta scuola genovese dei cantautori, in un’intervista della fine degli anni Cinquanta definisce i suoi brani “Canzoni a stato d’animo”, canzoni “che creano un’atmosfera passionale e serena”.
Oggi, per i 90 anni della nascita del “George Gershwin della canzone”, come lo definì Bruno Lauzi, mi torna in mente il racconto dettagliato che mi fece Giorgio Calabrese di “Arrivederci”. Lo intervistai perché il mio pezzo su questa canzone sarebbe finito in un bel libro collettivo a cura di Maurizio Becker e pubblicato nel 2011 da Coniglio editore, intitolato “Da Mameli a Vasco. Le 150 canzoni che hanno unito gli italiani”.
“Sai una cosa Zsa Zsa? Sono passati più di cinquant’anni, ma quando torno a Genova, ancora mi guardo attorno sperando di incrociare un viso che ti ricordi. E che potrebbe essere di tua figlia. Di tua nipote, chissà? Non ho più saputo nulla di te…”. Questo avrebbe voluto dirle non dirle, come in un film francese in bianco e nero. Certo, se ci fosse stato Facebook, Calabrese l’avrebbe rintracciata la sua Marisa, da Maria Luisa, detta Zsa Zsa. E invece da quella volta non si videro più.
Lo struggimento è già nell’eleganza del capoverso: arrivederci.
E’ la primavera del ’59, l’autore del testo incontra per caso una vecchia fiamma dei tempi della scuola, e accade l’irreparabile, ma lui è sposato e lei sta per farlo…
“Meglio lasciare in pace la gente che avrebbe dovuto vivere con noi”, mi ha raccontato lui qualche anno fa. “Si era appena consumato un grosso strappo, come quando ti tirano via un cerotto in malo modo. Carta e penna sul marmo bianco di un tavolo da cucina, a Genova. Poi, sono salito su un treno per Milano e non sono più tornato”. Calabrese consegna i suoi versi ad Umberto Bindi che impiega solo 5 minuti per musicarli e il brano entra in classifica il 6 giugno 1959 nella versione di Don Marino Barreto jr. (n.1 per 8 settimane), tirando la volata anche al 45 giri inciso dal co-autore che fa capoccetta in hit parade l’8 agosto. La prima ad inciderla, tuttavia, è una donna, Flo Sandon’s, perché suo marito, Natalino Otto, si innamora della canzone, ma si lascia andare al terzinato e sbaglia, non è più tempo... L’arrangiamento vincente si deve a Giulio Libano che vuole farne una ballad all’americana, ancor più indovinato l’interprete, Marino Barreto, che con la sua pronuncia cubana dice “con una estreta di mano”, che diventa il verso-tormentone.
“Quell’estate – racconta Calabrese – andai a trovare degli amici a Rimini. Una sera una ragazza mi chiese di ballare, finì il primo brano e dal juke-box partì “Arrivederci”. Sempre abbracciati, lei mi sussurrò “bella questa canzone di Bindi e Barreto”, ed io “Eh no, le parole sono mie”. Mi scansò dicendomi “ma fammi il piacere” e mi mollò solo, in mezzo alla pista. Ecco, questo è stato il mio primo successo personale come autore di canzoni”.
Innumerevoli le versioni: da Ernesto Bonino a Fred Bongusto, da Bruno Martino a Gianni Morandi, da Nilla Pizzi a Caterina Valente, da Ornella Vanoni ad Antonella Ruggiero. Nel 1960, proposta in duetto da Nicola Arigliano e Miranda Martino, si classifica seconda a “Canzonissima” e sempre del ’60 è la memorabile versione di Chet Baker, che la esegue voce e tromba, con l’arrangiamento di Piero Umiliani, nelle sequenze finali del film “Urlatori alla sbarra” di Lucio Fulci.
Timisoara Pinto
Oggi, per i 90 anni della nascita del “George Gershwin della canzone”, come lo definì Bruno Lauzi, mi torna in mente il racconto dettagliato che mi fece Giorgio Calabrese di “Arrivederci”. Lo intervistai perché il mio pezzo su questa canzone sarebbe finito in un bel libro collettivo a cura di Maurizio Becker e pubblicato nel 2011 da Coniglio editore, intitolato “Da Mameli a Vasco. Le 150 canzoni che hanno unito gli italiani”.
“Sai una cosa Zsa Zsa? Sono passati più di cinquant’anni, ma quando torno a Genova, ancora mi guardo attorno sperando di incrociare un viso che ti ricordi. E che potrebbe essere di tua figlia. Di tua nipote, chissà? Non ho più saputo nulla di te…”. Questo avrebbe voluto dirle non dirle, come in un film francese in bianco e nero. Certo, se ci fosse stato Facebook, Calabrese l’avrebbe rintracciata la sua Marisa, da Maria Luisa, detta Zsa Zsa. E invece da quella volta non si videro più.
Lo struggimento è già nell’eleganza del capoverso: arrivederci.
E’ la primavera del ’59, l’autore del testo incontra per caso una vecchia fiamma dei tempi della scuola, e accade l’irreparabile, ma lui è sposato e lei sta per farlo…
“Meglio lasciare in pace la gente che avrebbe dovuto vivere con noi”, mi ha raccontato lui qualche anno fa. “Si era appena consumato un grosso strappo, come quando ti tirano via un cerotto in malo modo. Carta e penna sul marmo bianco di un tavolo da cucina, a Genova. Poi, sono salito su un treno per Milano e non sono più tornato”. Calabrese consegna i suoi versi ad Umberto Bindi che impiega solo 5 minuti per musicarli e il brano entra in classifica il 6 giugno 1959 nella versione di Don Marino Barreto jr. (n.1 per 8 settimane), tirando la volata anche al 45 giri inciso dal co-autore che fa capoccetta in hit parade l’8 agosto. La prima ad inciderla, tuttavia, è una donna, Flo Sandon’s, perché suo marito, Natalino Otto, si innamora della canzone, ma si lascia andare al terzinato e sbaglia, non è più tempo... L’arrangiamento vincente si deve a Giulio Libano che vuole farne una ballad all’americana, ancor più indovinato l’interprete, Marino Barreto, che con la sua pronuncia cubana dice “con una estreta di mano”, che diventa il verso-tormentone.
“Quell’estate – racconta Calabrese – andai a trovare degli amici a Rimini. Una sera una ragazza mi chiese di ballare, finì il primo brano e dal juke-box partì “Arrivederci”. Sempre abbracciati, lei mi sussurrò “bella questa canzone di Bindi e Barreto”, ed io “Eh no, le parole sono mie”. Mi scansò dicendomi “ma fammi il piacere” e mi mollò solo, in mezzo alla pista. Ecco, questo è stato il mio primo successo personale come autore di canzoni”.
Innumerevoli le versioni: da Ernesto Bonino a Fred Bongusto, da Bruno Martino a Gianni Morandi, da Nilla Pizzi a Caterina Valente, da Ornella Vanoni ad Antonella Ruggiero. Nel 1960, proposta in duetto da Nicola Arigliano e Miranda Martino, si classifica seconda a “Canzonissima” e sempre del ’60 è la memorabile versione di Chet Baker, che la esegue voce e tromba, con l’arrangiamento di Piero Umiliani, nelle sequenze finali del film “Urlatori alla sbarra” di Lucio Fulci.
Timisoara Pinto
giovedì 21 aprile 2022
Il 21 aprile 2002 Patti Smith inaugurava l'Auditorium Parco della Musica, oggi intitolato ad Ennio Morricone. L'intervista di 20 anni fa
Per ogni piccola domanda ha sempre pronta una lunga e suadente risposta. Patti Smith è ancora una volta in Italia e all’areoporto di Fiumicino, dove è scesa ieri pomeriggio, ha incontrato la stampa per raccontare il suo “words and music”, concerto con cui l’artista di Chicago inaugurerà domani sera l’Auditorium-Parco della Musica.
Accompagnata dal suo compagno, il chitarrista Oliver Ray, Patricia Lee (questo il suo vero nome), ha raccontato la sua passione per il nostro paese, l’amore per Puccini con parole farcite di elementi letterari (ha anche mostrato la biografia di Maria Callas, sua ultima lettura), riferimenti alti ed altri, dettati dal background poetico che la caratterizza.
L’evento che la vedrà protagonista solo apparentemente stupisce per l’accostamento di due mondi così distanti, la Rimbaud del rock ed il tempio della classica. In realtà coniuga perfettamente le due anime della Smith: quella affascinata dall’opera (“ultimamente ascolto la Callas – dichiara l’artista - perché sto studiando la mia voce) e quella devota alla "musica giovane". All’età di nove anni, infatti, due cose hanno segnato la sua vita: una rappresentazione di “Madama Butterfly” e Little Richard.
Che effetto le fa essere la prima artista rock ad esibirsi nel nuovo auditorium di Roma?
Sono veramente onorata, anche perché in America per le idee che ho, non mi avrebbero mai invitata ad un’inaugurazione di tale importanza. Da una parte sono anche un po’ sorpresa, ma dall’altra no, perché in Italia sono sempre stata ricevuta con grande calore. Ricordo la prima volta all’aeroporto di Firenze nel 1979. Fui accolta da un gruppo di paparazzi, ma non capii subito che stessero inseguendo proprio me. Con i miei musicisti ci guardammo intorno, pensando che forse dopo di noi fossero scesi dall'aereo Marcello Mastroianni e Federico Fellini.
Il suo ultimo concerto tenuto a Roma l’estate scorsa lo ha dedicato ad Anna Magnani. Quello di domani sera?
Lo dedico al Papa. So che in questo momento non sta molto bene e vorrei trasmettergli un po’ della mia forza e della mia energia. Io non sono cattolica, ma in lui non vedo la religione, vedo solo un uomo che sta tentando di tenere il mondo unito.
Il suo pensiero sul terrorismo
Sono americana, ma la mia filosofia del terrorismo è diversa dalla filosofia del mio paese. Nessun paese può ambire ad essere il numero uno. Io amo il mio paese, in senso patriottico ma non nazionalistico. La cosa più pericolosa non è la bomba in sé, ma quel meccanismo che fa di un semplice corpo una carica di energia distruttrice. Il più grande pericolo che c’è oggi è la forza spirituale, se usata negativamente.
Che ricordo ha del pubblico italiano?
In Italia ho trovato sempre grande rispetto e ospitalità per il mio spirito rivoluzionario. Una volta sono finita in un posto enorme senza rendermi conto di dove fossi. C’era tantissimo pubblico e quella gioia, quell’eccitamento che li animava mi hanno subito contagiata.
Timisoara Pinto
L’evento che la vedrà protagonista solo apparentemente stupisce per l’accostamento di due mondi così distanti, la Rimbaud del rock ed il tempio della classica. In realtà coniuga perfettamente le due anime della Smith: quella affascinata dall’opera (“ultimamente ascolto la Callas – dichiara l’artista - perché sto studiando la mia voce) e quella devota alla "musica giovane". All’età di nove anni, infatti, due cose hanno segnato la sua vita: una rappresentazione di “Madama Butterfly” e Little Richard.
Che effetto le fa essere la prima artista rock ad esibirsi nel nuovo auditorium di Roma?
Sono veramente onorata, anche perché in America per le idee che ho, non mi avrebbero mai invitata ad un’inaugurazione di tale importanza. Da una parte sono anche un po’ sorpresa, ma dall’altra no, perché in Italia sono sempre stata ricevuta con grande calore. Ricordo la prima volta all’aeroporto di Firenze nel 1979. Fui accolta da un gruppo di paparazzi, ma non capii subito che stessero inseguendo proprio me. Con i miei musicisti ci guardammo intorno, pensando che forse dopo di noi fossero scesi dall'aereo Marcello Mastroianni e Federico Fellini.
Il suo ultimo concerto tenuto a Roma l’estate scorsa lo ha dedicato ad Anna Magnani. Quello di domani sera?
Lo dedico al Papa. So che in questo momento non sta molto bene e vorrei trasmettergli un po’ della mia forza e della mia energia. Io non sono cattolica, ma in lui non vedo la religione, vedo solo un uomo che sta tentando di tenere il mondo unito.
Il suo pensiero sul terrorismo
Sono americana, ma la mia filosofia del terrorismo è diversa dalla filosofia del mio paese. Nessun paese può ambire ad essere il numero uno. Io amo il mio paese, in senso patriottico ma non nazionalistico. La cosa più pericolosa non è la bomba in sé, ma quel meccanismo che fa di un semplice corpo una carica di energia distruttrice. Il più grande pericolo che c’è oggi è la forza spirituale, se usata negativamente.
Che ricordo ha del pubblico italiano?
In Italia ho trovato sempre grande rispetto e ospitalità per il mio spirito rivoluzionario. Una volta sono finita in un posto enorme senza rendermi conto di dove fossi. C’era tantissimo pubblico e quella gioia, quell’eccitamento che li animava mi hanno subito contagiata.
Timisoara Pinto
giovedì 24 febbraio 2022
ENNIO MORRICONE: "L'America non mi avrà" Intervista del 2002 in occasione della laurea honoris causa in DAMS all'Università Tor Vergata di Roma
L’Università di Roma Tor Vergata conferità questa mattina la laurea honoris causa in DAMS ad Ennio Morricone. Un riconoscimento accademico di grande prestigio per il settantaquattrenne maestro romano e per tutta la musica italiana, da qualche anno al centro di studi e di un dibattito più ampio da parte del mondo accademico. “Morricone – si legge nella motivazione – non è solo un grande autore di bellissime musiche che hanno caratterizzato tanti films di questi ultimi anni, ma è anche un compositore saldamente radicato nella musica colta contemporanea e nelle esperienze dell’avanguardia musicale non solo italiana”.
Maestro, non è la prima laurea honoris causa che riceve?
Ne ho ricevuta una in Lingua e letteratura straniere dall’Università di Cagliari , e l’Università di Madrid mi ha insignito del titolo di Claustro universitario delle arti.
Che significato ha per lei la cerimonia di questa mattina?
Si tratta, senz’altro della laurea più adatta e più giusta che potessero conferirmi. E poi, riceverla qui a Roma, nella mia città, mi rende orgoglioso.
Lei ha composto 400 colonne sonore in 41 anni di carriera: a cosa vorrebbe dedicarsi di più oggi?
Il cinema è sempre la mia principale attività, i prossimi film saranno “Senso 45” di Tinto Brass e “Il Papa Buono” di Ricky Tognazzi, ma vorrei più tempo per comporre solo per me. Sto preparando un pezzo per il Festival di Ravenna, dal titolo “Voci dal silenzio”, che, in quell’occasione sarà diretto da Riccardo Muti con l’Orchestra della Scala.
Come direttore d’orchestra nel suo curriculum figurano anche due Sanremo, nel 1964 e nel 1966. Guarderà quest’anno il festival?
No, non lo guarderò perché vado a dormire presto. Feci Sanremo perché a quell’epoca lavoravo per la RCA e mi occupavo della cura dei pezzi di alcuni artisti. Tra questi mi ricordo Paul Anka che nel 1964 andò al festival e la RCA mi chiese di accompagnarlo.
Lei ha sempre privilegiato la sua ‘romanità’ anche nelle scelte lavorative, come ha fatto a non cedere mai alla tentazione di andare in America?
Non mi sposterò mai da Roma. Pensi che una volta mi avrebbero persino regalato una villa, se avessi accettato di andare a lavorare negli Stati Uniti. Sono riusciti a portarmi lì per la nomitation ottenuta con “Malena”, il film di Tornatore. Ma sentivo che anche quella, la quinta nella mia carriera, non sarebbe stata la volta buona.
Timisoara Pinto
Maestro, non è la prima laurea honoris causa che riceve?
Ne ho ricevuta una in Lingua e letteratura straniere dall’Università di Cagliari , e l’Università di Madrid mi ha insignito del titolo di Claustro universitario delle arti.
Che significato ha per lei la cerimonia di questa mattina?
Si tratta, senz’altro della laurea più adatta e più giusta che potessero conferirmi. E poi, riceverla qui a Roma, nella mia città, mi rende orgoglioso.
Lei ha composto 400 colonne sonore in 41 anni di carriera: a cosa vorrebbe dedicarsi di più oggi?
Il cinema è sempre la mia principale attività, i prossimi film saranno “Senso 45” di Tinto Brass e “Il Papa Buono” di Ricky Tognazzi, ma vorrei più tempo per comporre solo per me. Sto preparando un pezzo per il Festival di Ravenna, dal titolo “Voci dal silenzio”, che, in quell’occasione sarà diretto da Riccardo Muti con l’Orchestra della Scala.
Come direttore d’orchestra nel suo curriculum figurano anche due Sanremo, nel 1964 e nel 1966. Guarderà quest’anno il festival?
No, non lo guarderò perché vado a dormire presto. Feci Sanremo perché a quell’epoca lavoravo per la RCA e mi occupavo della cura dei pezzi di alcuni artisti. Tra questi mi ricordo Paul Anka che nel 1964 andò al festival e la RCA mi chiese di accompagnarlo.
Lei ha sempre privilegiato la sua ‘romanità’ anche nelle scelte lavorative, come ha fatto a non cedere mai alla tentazione di andare in America?
Non mi sposterò mai da Roma. Pensi che una volta mi avrebbero persino regalato una villa, se avessi accettato di andare a lavorare negli Stati Uniti. Sono riusciti a portarmi lì per la nomitation ottenuta con “Malena”, il film di Tornatore. Ma sentivo che anche quella, la quinta nella mia carriera, non sarebbe stata la volta buona.
Timisoara Pinto
giovedì 17 febbraio 2022
Agelo Branduardi: "Ho rubato tante diverse marmellate, ma il pubblico mi ha sempre perdonato"
Riprendiamo il cammino dove si era interrotto. Alla fine del 2019 era uscito un nuovo album, poi il tour bloccato per la pandemia. Come ha trascorso questo tempo sospeso e che effetto le fa ora tornare in teatro?
"Per un anno e mezzo non ho fatto praticamente nulla, non sono riuscito a suonare una nota, né ad ascoltare la mia musica preferita, Bach e Springsteen, per cui sono ripartito con grande emozione, ma anche con la speranza che le cose si possano sistemare in maniera definitiva. Il primo pensiero, guardando il pubblico, è bentornati alla vita".
Però ha scritto due nuovi brani durante il lockdown…
"Sì, è vero, aver mantenuto una certa creatività anche in un momento così drammatico, non mi dispiace. Ho scritto “Kirie Eleison (Signore abbi pietà)” , e “Piccolo David”. Con il primo brano, pensavo di aver alzato un grido di dolore e invece la gente l’ha interpretata al contrario, come spesso succede. Gli artisti fanno delle cose e poi gli viene spiegato dal pubblico che è tutt’altro. Nel “Kirie” che è tutto in SOL minore, una tonalità triste, metto alla fine 15 secondi di SOL maggiore che invece è un accordo grande, pieno di speranza e il pubblico ha colto quello. “Piccolo David”, invece credo che uscirà per Pasqua perché si parla di “Alleluja”, un brano abbastanza sfrenato, pieno di gioia, non certo adatto ai momenti che abbiamo vissuto. Solo le uniche due cose che sono riuscito a fare".
E li ascolteremo in questo tour, insieme ai brani dell’album “Il cammino dell’anima” con testi, come sempre a cura di sua moglie Luisa Zappa, tradotti e rielaborati dall’opera di Ildegarda di Bingen. Molti ragazzi sono affascinati dalla figura di Hildegard von Bingen, una vera icona. Nel 2012 è stata dichiarata dottore della Chiesa da papa Benedetto XVI. Lei cosa ha voluto cogliere della sua opera?
"Io non la conoscevo, devo essere sincero l’ho scoperta per caso,. Mi interessava sapere se esistesse una donna che avesse scritto musica in passato e ho trovato Ildegarda. Una figura straordinaria: alla fine dell’anno Mille compare questa donna che preannuncia il Rinascimento, l’Umanesimo, sa fare tutto, scrivere parla da pari a pari con Papi e Imperatori, è un medico, una fitoterapista e, soprattutto, è una grande musicista. Ha fondato questo suo ordine in cui le suore interpretavano le sue musiche, le danzavano, vestivano semplici tuniche bianche e non avevano copricapo, che è una cosa incredibile per delle monache".
Cos’era la musica per Ildegarda nell’anno Mille? "Lei la chiama “Sinfonia”, ritiene che la musica sia la forma più alta forma di espressione, è l’arte più astratta che ci sia. Scrive sugli stilemi dell’epoca, ma poi, a volte, esula completamente dal momento storico. C’è un brano, che è quello che conclude il mio album, che si intitola “Generosa”, che potrebbe essere un’aria romantica. Aveva visto lontanissimo anche sui diritti delle donne, è una protofemminista di mille anni fa, già solo per il fatto di pensare un brano musicale in cui la donna viene chiamata “generosa”. E' fuori da ogni schema il termine generosa".
Della scena attuale, la cosiddetta musica che piace ai “giovani”, cosa la incuriosisce, cosa le piace e cosa non le piace.
"Come sempre c’è il bello e il brutto. La musica di oggi a volte è un po’ inutile, ma non mi sento in grado di dare giudizi".
Nella seconda parte il concerto diventa antologico, con brani entrati nella memoria collettiva come “Cogli la prima mela” e soprattutto “Alla fiera dell’est, un tormentone attraverso le generazioni.
"Nulla sarà risparmiato al pubblico. Io tengo molto alle cose che ho fatto e hanno avuto successo, a differenza di altri miei colleghi che le rifiutano, io no, vorrei averne fatte mille di Fiere dell’est! Mi garantisce un pochino di immortalità, perché i bambini che la cantano a scuola non sanno chi sia Branduardi, però il topolino lo conoscono, e questo vuol dire che il brano non mi appartiene più, è di tutti, è diventato patrimonio popolare. Poi, ragionevolmente, questi bambini la canteranno a loro volta ai loro figli, quindi diventa una catena di Sant’Antonio".
Una musica del mondo, in cui sono confluite varie ispirazioni, comprese le musiche di tradizione popolare, la musica antica, sacra, il prog, non sempre ha tentato di replicare quel successo…
“Se posso essere immodesto, la world music la praticavo quando ancora non esisteva, perché mi veniva naturale, io sono molto curioso. Dopo aver fatto studi musicali classici, mi piaceva andare ad ascoltare ciò che classico non era ritenuto, a torto o a ragione, e quindi soprattutto la musica popolare e quella antica che ai miei tempi non venivano insegnate. Ho fatto addirittura otto dischi di musica antica che si chiamano “Futuro antico” per vedere se per caso la crisi della musica occidentale che non ho inventato io, fosse risolvibile facendo un passo indietro, che significherebbe farne due avanti, poi questo non so se succede, ma in questo modo, pur sbagliando tante volte, sono andato in quella direzione. Io agisco soltanto per il mio istinto e per il mio piacere e so che quando il mio piacere e la mia sorpresa sono grandi, normalmente lo sono anche per il mio pubblico. Un pubblico fedelissimo che ha accettato anche delle cadute che posso aver fatto, perché sperimentando, toccando di qua e di là, rubando tante diverse marmellate, posso aver commesso degli errori, anzi senz’altro li ho commessi, però mi sono stati perdonati. Per cui, non posso che essere grato al mio pubblico".
"Per un anno e mezzo non ho fatto praticamente nulla, non sono riuscito a suonare una nota, né ad ascoltare la mia musica preferita, Bach e Springsteen, per cui sono ripartito con grande emozione, ma anche con la speranza che le cose si possano sistemare in maniera definitiva. Il primo pensiero, guardando il pubblico, è bentornati alla vita".
Però ha scritto due nuovi brani durante il lockdown…
"Sì, è vero, aver mantenuto una certa creatività anche in un momento così drammatico, non mi dispiace. Ho scritto “Kirie Eleison (Signore abbi pietà)” , e “Piccolo David”. Con il primo brano, pensavo di aver alzato un grido di dolore e invece la gente l’ha interpretata al contrario, come spesso succede. Gli artisti fanno delle cose e poi gli viene spiegato dal pubblico che è tutt’altro. Nel “Kirie” che è tutto in SOL minore, una tonalità triste, metto alla fine 15 secondi di SOL maggiore che invece è un accordo grande, pieno di speranza e il pubblico ha colto quello. “Piccolo David”, invece credo che uscirà per Pasqua perché si parla di “Alleluja”, un brano abbastanza sfrenato, pieno di gioia, non certo adatto ai momenti che abbiamo vissuto. Solo le uniche due cose che sono riuscito a fare".
E li ascolteremo in questo tour, insieme ai brani dell’album “Il cammino dell’anima” con testi, come sempre a cura di sua moglie Luisa Zappa, tradotti e rielaborati dall’opera di Ildegarda di Bingen. Molti ragazzi sono affascinati dalla figura di Hildegard von Bingen, una vera icona. Nel 2012 è stata dichiarata dottore della Chiesa da papa Benedetto XVI. Lei cosa ha voluto cogliere della sua opera?
"Io non la conoscevo, devo essere sincero l’ho scoperta per caso,. Mi interessava sapere se esistesse una donna che avesse scritto musica in passato e ho trovato Ildegarda. Una figura straordinaria: alla fine dell’anno Mille compare questa donna che preannuncia il Rinascimento, l’Umanesimo, sa fare tutto, scrivere parla da pari a pari con Papi e Imperatori, è un medico, una fitoterapista e, soprattutto, è una grande musicista. Ha fondato questo suo ordine in cui le suore interpretavano le sue musiche, le danzavano, vestivano semplici tuniche bianche e non avevano copricapo, che è una cosa incredibile per delle monache".
Cos’era la musica per Ildegarda nell’anno Mille? "Lei la chiama “Sinfonia”, ritiene che la musica sia la forma più alta forma di espressione, è l’arte più astratta che ci sia. Scrive sugli stilemi dell’epoca, ma poi, a volte, esula completamente dal momento storico. C’è un brano, che è quello che conclude il mio album, che si intitola “Generosa”, che potrebbe essere un’aria romantica. Aveva visto lontanissimo anche sui diritti delle donne, è una protofemminista di mille anni fa, già solo per il fatto di pensare un brano musicale in cui la donna viene chiamata “generosa”. E' fuori da ogni schema il termine generosa".
Della scena attuale, la cosiddetta musica che piace ai “giovani”, cosa la incuriosisce, cosa le piace e cosa non le piace.
"Come sempre c’è il bello e il brutto. La musica di oggi a volte è un po’ inutile, ma non mi sento in grado di dare giudizi".
Nella seconda parte il concerto diventa antologico, con brani entrati nella memoria collettiva come “Cogli la prima mela” e soprattutto “Alla fiera dell’est, un tormentone attraverso le generazioni.
"Nulla sarà risparmiato al pubblico. Io tengo molto alle cose che ho fatto e hanno avuto successo, a differenza di altri miei colleghi che le rifiutano, io no, vorrei averne fatte mille di Fiere dell’est! Mi garantisce un pochino di immortalità, perché i bambini che la cantano a scuola non sanno chi sia Branduardi, però il topolino lo conoscono, e questo vuol dire che il brano non mi appartiene più, è di tutti, è diventato patrimonio popolare. Poi, ragionevolmente, questi bambini la canteranno a loro volta ai loro figli, quindi diventa una catena di Sant’Antonio".
Una musica del mondo, in cui sono confluite varie ispirazioni, comprese le musiche di tradizione popolare, la musica antica, sacra, il prog, non sempre ha tentato di replicare quel successo…
“Se posso essere immodesto, la world music la praticavo quando ancora non esisteva, perché mi veniva naturale, io sono molto curioso. Dopo aver fatto studi musicali classici, mi piaceva andare ad ascoltare ciò che classico non era ritenuto, a torto o a ragione, e quindi soprattutto la musica popolare e quella antica che ai miei tempi non venivano insegnate. Ho fatto addirittura otto dischi di musica antica che si chiamano “Futuro antico” per vedere se per caso la crisi della musica occidentale che non ho inventato io, fosse risolvibile facendo un passo indietro, che significherebbe farne due avanti, poi questo non so se succede, ma in questo modo, pur sbagliando tante volte, sono andato in quella direzione. Io agisco soltanto per il mio istinto e per il mio piacere e so che quando il mio piacere e la mia sorpresa sono grandi, normalmente lo sono anche per il mio pubblico. Un pubblico fedelissimo che ha accettato anche delle cadute che posso aver fatto, perché sperimentando, toccando di qua e di là, rubando tante diverse marmellate, posso aver commesso degli errori, anzi senz’altro li ho commessi, però mi sono stati perdonati. Per cui, non posso che essere grato al mio pubblico".
domenica 31 ottobre 2021
Da una buona novella all'altra: De André nei panni di Pasolini
Con Dori Ghezzi e Francesco Giunta, in occasione dell'uscita dell'album "La buona novella" in siciliano
T.: Francesco Giunta ha tradotto, con la consulenza del linguista Giovanni Ruffino, un intero album di Fabrzio De André. Perché proprio “La buona novella”?
F.G.: “La buona novella” si è innestata nella mia vita diventandone parte, avevo solo diciotto anni quando è uscita. La collaborazione di Ruffino e i consigli anche di un altro linguista, il professor Roberto Sottile, sono arrivati in una fase successiva di revisione e di verifica di ciò che avevo fatto. Ho scelto questo album di De André perché è stato un faro per me.
T.: Lei nel libretto, infatti, scrive: “Appartengo alla schiera di quanti sono convinti che l’opera di Fabrizio De André sia stata fondamentale nel suggerire loro la possibilità di essere e di diventare migliori rispetto a quanto previsto dal pensiero dominante ai loro tempi”
F. G.: Mi aiutò a crescere, ne sono assolutamente convinto. Non vuole essere un giudizio positivo su me stesso, dico che è stato fondamentale poter essere migliori grazie al lavoro di De André . Così, ho sentito l’esigenza di riavvicinarmi a quelle parole che tanto avevano seminato dentro di me, rileggendole nella lingua con cui da anni ho scelto di esprimermi.
T.: Prendiamo “Il testamento di Tito”, il testo si discosta molto dall’originale.
F.G.: Sì perché un’opera come “La buona novella” non poteva essere tradita perché tradotta, era necessario riadattarla. Un altro esempio è “Il ritorno di Giuseppe”. De André canta: “Un asino dai passi uguali compagno del tuo ritorno”, io in siciliano non potevo usare “sciecco”, perché ha un’accezione negativa. Così l’asino è diventato “l’armaluzzo compagno a l’arsura”. Questo è stato il lavoro più delicato, cercare delle metafore alternative che non tradissero l’intenzione originale.
T.: E’ solo per una coincidenza anagrafica, perché “La buona novella” è l’album che ha segnato i suoi 18 anni o perché ha un significato particolare rispetto ad altri dischi di De André?
F. G: Amo tutta l’opera di Fabrizio e questo è evidente, non ha neanche senso che io lo dica. Però credo che con “La buona novella” Fabrizio abbia raggiunto il suo apice, un lavoro di una sintesi e di una profondità uniche, è un disco fuori dal tempo.
T.: Dori Ghezzi, per lei è così?
D.G.: E’ incredibile come Francesco Giunta sia stato fedele nella traduzione e sia riuscito a dare alle parole scelte la sonorità che Fabrizio cercava. Il complimento che Leonard Cohen ha fatto a Fabrizio è stato quello: si è stupito per la fedeltà della traduzione e per la sonorità delle parole che usava. E questo è quello che ha fatto Francesco.
T.: Francesco cosa vuole aggiungere rispetto a quello che ha appena detto Dori Ghezzi sul suono dell’album?
F.G.: Volendo tradurre senza tradire, è stato necessario rimanere fedeli, per quanto possibile, al suono originale. In tal senso, l’aver fatto ricorso solo al pianoforte e alle percussioni, laddove l’incedere e l’incalzare dei brani lo richiedeva, mi ha consentito di stare vicino all'impianto classico dell’orchestra utilizzata dal maestro Giampiero Reverberi nell’album di De André. Per quanto riguarda il testo e quindi la parola cantata, ho cercato di mantenere lo schema delle rime voluto da Fabrizio e quindi la rima baciata, la rima alternata o l’assonanza, dove ricorreva. Tutto questo evitando un uso meccanico di questo criterio.
T.: Possiamo dire che “La buona novella” sia l’album più pasoliniano di De André?
D.G.: “Forse più che Pasolini, mi ricorda un altro autore, Josè Saramago che ha scritto “Il Vangelo secondo Gesù Cristo”, dove è evidente che anche lui si sia ispirato ai Vangeli apocrifi. E' impressionante come alcune frasi siano identiche, la cosa mi ha colpito moltissimo, e Saramago l’ha scritto dopo Fabrizio. Nessuno ha copiato da nessuno, non voglio dire questo, evidentemente entrambi si sono rifatti molto fedelmente ai Vangeli apocrifi. E’ incredibile come la loro visione sia molto vicina, nell’intendere la spiritualità e rispettare l’emblema femminile e “La buona Novella” è impostata, soprattutto sulla presenza di Maria”.
T.: “La buona novella” in siciliano con la pianista Beatrice Cerami e le quattro voci di Cecilia Pitino, Alessandra Ristuccia, Laura Mollica, Giulia Mei diventa, così, un’opera corale femminile.
D.G.: La scelta di quattro donne, contrariamente al fatto che la voce sia soltanto maschile nell’originale di Fabrizio, arriva profondamente.
F.G.: Ti dirò di più: le donne intorno a questo lavoro sono nove. In scena ci sarà una percussionista, poi c’è Maria Cristina Di Giuseppe che ha scritto una parte dei testi in italiano che faranno parte dello spettacolo teatrale, di cui sarà la regista, ci sarà un’attrice che li reciterà, e c’è Dori che le raccoglie tutte e che, dall’alto della sua affettuosa complicità, ci ha dato il coraggio per affrontare un progetto così grande.
T.: Qual è l’attualità de “La buona Novella”?
D.G.: E’ quella, come Fabrizio ha fatto, di continuare a salvaguardare gli idiomi locali che poi sono idiomi internazionali, secondo me. Fabrizio sarebbe stato un fanatico di questa operazione.
T.: Qual era il rapporto di De André con il dialetto siciliano, con la Sicilia?
D.G.: Ma sai, lui ha cantato in napoletano, piemontese, genovese, in lombardo addirittura, è uno che non si è mai tirato indietro. Non l’ha solo detto, l’ha sempre fatto. Poi, il siciliano è comprensibile a tutti, lo sentiamo circolare, contrariamente al lombardo che non lo conosce più nessuno e questa è una carenza enorme.
G.G.: Questo problema della perdita dei dialetti è grave, un grande linguista ha detto “I dialetti sono gli affluenti della lingua italiana”. Senza i dialetti la nostra lingua sparirà. Mantenere gli idiomi non è un richiudersi, ma è mantenere viva questa ricchezza, questa grande varietà.
T.: Dori, qual era invece il rapporto tra De André e Pasolini?
D.G: Non so se Pasolini ascoltasse Fabrizio, nessuno me ne ha mai parlato. Però Fabrizio ha letto molto Pasolini e abbiamo libri con i suoi appunti, sottolineature, annotazioni, commenti e ci sono delle cose molto interessanti e mi piacerebbe fare un lavoro su questa sua ricerca.
T. : Forse anche spunti per canzoni?
D.G.: No, sono commenti dove lo trovi d’accordo o in disaccordo.
T.: Un esempio?
D.G.: C’è un libro soprattutto, quello che è stato pubblicato postumo.
T.: “Petrolio”?
D.G. : Sì, Fabrizio sosteneva che se Pasolini fosse stato in vita non avrebbe permesso di pubblicarlo. Lo trova un po’ snaturato, non giudica tanto Pasolini, ma l’operazione di libertinaggio degli editori. Si è un po’ messo nei panni di Pasolini.
T.: Francesco Giunta ha tradotto, con la consulenza del linguista Giovanni Ruffino, un intero album di Fabrzio De André. Perché proprio “La buona novella”?
F.G.: “La buona novella” si è innestata nella mia vita diventandone parte, avevo solo diciotto anni quando è uscita. La collaborazione di Ruffino e i consigli anche di un altro linguista, il professor Roberto Sottile, sono arrivati in una fase successiva di revisione e di verifica di ciò che avevo fatto. Ho scelto questo album di De André perché è stato un faro per me.
T.: Lei nel libretto, infatti, scrive: “Appartengo alla schiera di quanti sono convinti che l’opera di Fabrizio De André sia stata fondamentale nel suggerire loro la possibilità di essere e di diventare migliori rispetto a quanto previsto dal pensiero dominante ai loro tempi”
F. G.: Mi aiutò a crescere, ne sono assolutamente convinto. Non vuole essere un giudizio positivo su me stesso, dico che è stato fondamentale poter essere migliori grazie al lavoro di De André . Così, ho sentito l’esigenza di riavvicinarmi a quelle parole che tanto avevano seminato dentro di me, rileggendole nella lingua con cui da anni ho scelto di esprimermi.
T.: Prendiamo “Il testamento di Tito”, il testo si discosta molto dall’originale.
F.G.: Sì perché un’opera come “La buona novella” non poteva essere tradita perché tradotta, era necessario riadattarla. Un altro esempio è “Il ritorno di Giuseppe”. De André canta: “Un asino dai passi uguali compagno del tuo ritorno”, io in siciliano non potevo usare “sciecco”, perché ha un’accezione negativa. Così l’asino è diventato “l’armaluzzo compagno a l’arsura”. Questo è stato il lavoro più delicato, cercare delle metafore alternative che non tradissero l’intenzione originale.
T.: E’ solo per una coincidenza anagrafica, perché “La buona novella” è l’album che ha segnato i suoi 18 anni o perché ha un significato particolare rispetto ad altri dischi di De André?
F. G: Amo tutta l’opera di Fabrizio e questo è evidente, non ha neanche senso che io lo dica. Però credo che con “La buona novella” Fabrizio abbia raggiunto il suo apice, un lavoro di una sintesi e di una profondità uniche, è un disco fuori dal tempo.
T.: Dori Ghezzi, per lei è così?
D.G.: E’ incredibile come Francesco Giunta sia stato fedele nella traduzione e sia riuscito a dare alle parole scelte la sonorità che Fabrizio cercava. Il complimento che Leonard Cohen ha fatto a Fabrizio è stato quello: si è stupito per la fedeltà della traduzione e per la sonorità delle parole che usava. E questo è quello che ha fatto Francesco.
T.: Francesco cosa vuole aggiungere rispetto a quello che ha appena detto Dori Ghezzi sul suono dell’album?
F.G.: Volendo tradurre senza tradire, è stato necessario rimanere fedeli, per quanto possibile, al suono originale. In tal senso, l’aver fatto ricorso solo al pianoforte e alle percussioni, laddove l’incedere e l’incalzare dei brani lo richiedeva, mi ha consentito di stare vicino all'impianto classico dell’orchestra utilizzata dal maestro Giampiero Reverberi nell’album di De André. Per quanto riguarda il testo e quindi la parola cantata, ho cercato di mantenere lo schema delle rime voluto da Fabrizio e quindi la rima baciata, la rima alternata o l’assonanza, dove ricorreva. Tutto questo evitando un uso meccanico di questo criterio.
T.: Possiamo dire che “La buona novella” sia l’album più pasoliniano di De André?
D.G.: “Forse più che Pasolini, mi ricorda un altro autore, Josè Saramago che ha scritto “Il Vangelo secondo Gesù Cristo”, dove è evidente che anche lui si sia ispirato ai Vangeli apocrifi. E' impressionante come alcune frasi siano identiche, la cosa mi ha colpito moltissimo, e Saramago l’ha scritto dopo Fabrizio. Nessuno ha copiato da nessuno, non voglio dire questo, evidentemente entrambi si sono rifatti molto fedelmente ai Vangeli apocrifi. E’ incredibile come la loro visione sia molto vicina, nell’intendere la spiritualità e rispettare l’emblema femminile e “La buona Novella” è impostata, soprattutto sulla presenza di Maria”.
T.: “La buona novella” in siciliano con la pianista Beatrice Cerami e le quattro voci di Cecilia Pitino, Alessandra Ristuccia, Laura Mollica, Giulia Mei diventa, così, un’opera corale femminile.
D.G.: La scelta di quattro donne, contrariamente al fatto che la voce sia soltanto maschile nell’originale di Fabrizio, arriva profondamente.
F.G.: Ti dirò di più: le donne intorno a questo lavoro sono nove. In scena ci sarà una percussionista, poi c’è Maria Cristina Di Giuseppe che ha scritto una parte dei testi in italiano che faranno parte dello spettacolo teatrale, di cui sarà la regista, ci sarà un’attrice che li reciterà, e c’è Dori che le raccoglie tutte e che, dall’alto della sua affettuosa complicità, ci ha dato il coraggio per affrontare un progetto così grande.
T.: Qual è l’attualità de “La buona Novella”?
D.G.: E’ quella, come Fabrizio ha fatto, di continuare a salvaguardare gli idiomi locali che poi sono idiomi internazionali, secondo me. Fabrizio sarebbe stato un fanatico di questa operazione.
T.: Qual era il rapporto di De André con il dialetto siciliano, con la Sicilia?
D.G.: Ma sai, lui ha cantato in napoletano, piemontese, genovese, in lombardo addirittura, è uno che non si è mai tirato indietro. Non l’ha solo detto, l’ha sempre fatto. Poi, il siciliano è comprensibile a tutti, lo sentiamo circolare, contrariamente al lombardo che non lo conosce più nessuno e questa è una carenza enorme.
G.G.: Questo problema della perdita dei dialetti è grave, un grande linguista ha detto “I dialetti sono gli affluenti della lingua italiana”. Senza i dialetti la nostra lingua sparirà. Mantenere gli idiomi non è un richiudersi, ma è mantenere viva questa ricchezza, questa grande varietà.
T.: Dori, qual era invece il rapporto tra De André e Pasolini?
D.G: Non so se Pasolini ascoltasse Fabrizio, nessuno me ne ha mai parlato. Però Fabrizio ha letto molto Pasolini e abbiamo libri con i suoi appunti, sottolineature, annotazioni, commenti e ci sono delle cose molto interessanti e mi piacerebbe fare un lavoro su questa sua ricerca.
T. : Forse anche spunti per canzoni?
D.G.: No, sono commenti dove lo trovi d’accordo o in disaccordo.
T.: Un esempio?
D.G.: C’è un libro soprattutto, quello che è stato pubblicato postumo.
T.: “Petrolio”?
D.G. : Sì, Fabrizio sosteneva che se Pasolini fosse stato in vita non avrebbe permesso di pubblicarlo. Lo trova un po’ snaturato, non giudica tanto Pasolini, ma l’operazione di libertinaggio degli editori. Si è un po’ messo nei panni di Pasolini.
Iscriviti a:
Post (Atom)